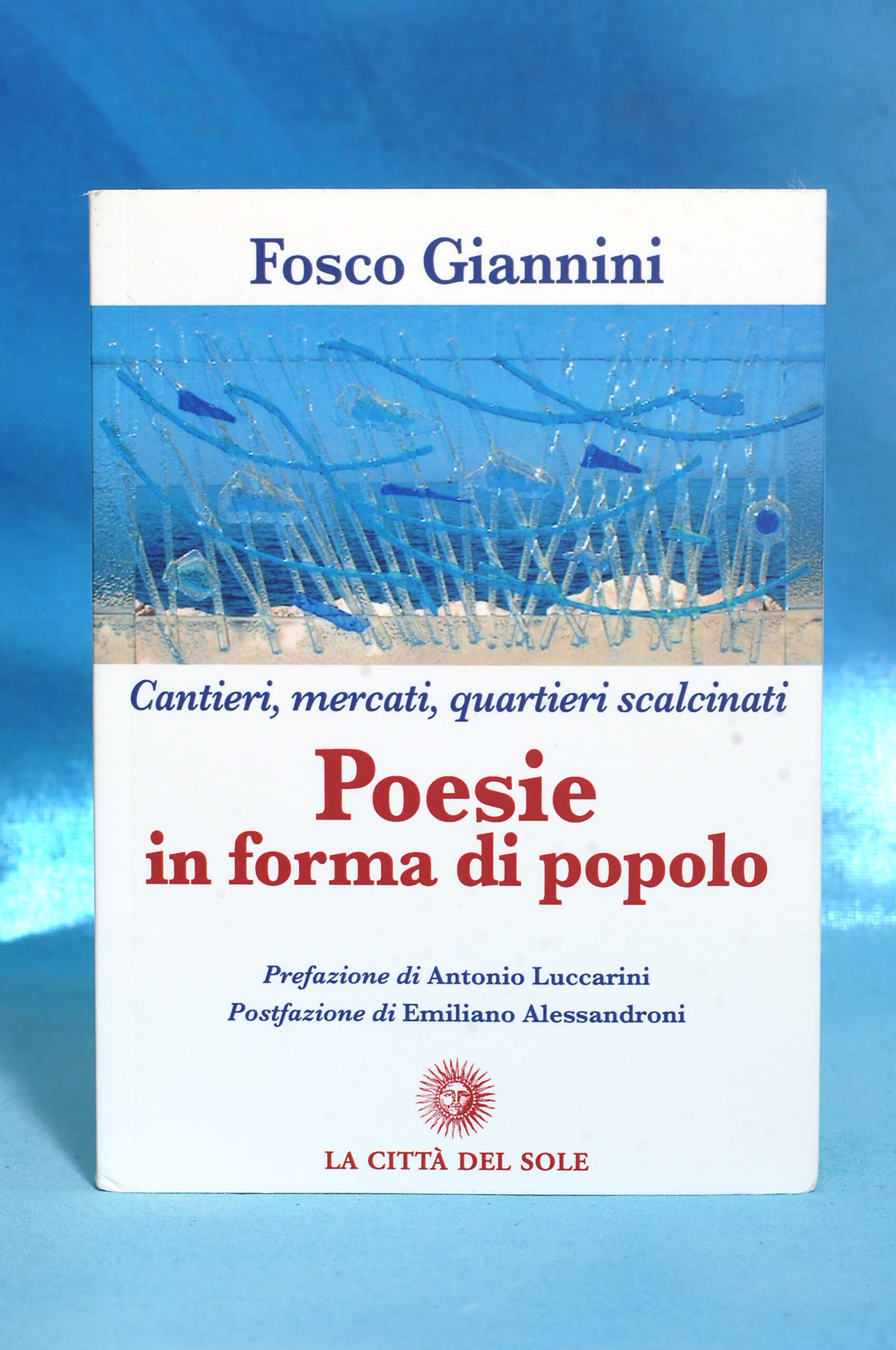di Ufficio Stampa. Il Compagno Fosco Giannini, responsabile Esteri della Segreteria nazionale del PCI, ha scritto un libro di poesie, nel fare i complimenti alla sua indubbia versatilità, alla passione e al suo estro, ne pubblichiamo la post fazione di Emiliano Alessandroni, che collabora con la cattedra di “Storia della Filosofia Politica”, ” Storia della Filosofia Moderna” e “Letterature Comparate” dell’Università di Urbino ed autore di saggi di Teoria della Letteratura.
Canti di un universo sociale in decomposizione (di Emiliano Alessandroni)
«Parlavano tutti nella mia tragedia, donna o schiavo che fossero!». A queste parole, pronunciate da Euripide nelle Rane di Aristofane, replica il personaggio di Eschilo, palesando, senza troppi indugi, il pensiero dell’autore: «Svergognato, non ti dovevano accoppare?»[1]. Dalla parte di Aristofane si schiererà, molti secoli più tardi, Friedrich Nietzsche, che, nel ricercare le origini di quelle rivolte operaie, suscettibili a suo avviso di intorpidire la vita dello spirito, punterà il dito proprio contro il teatro di Euripide, reo ai suoi occhi di aprire il sipario a quello «schiavo domestico bonario e scaltro, che così spesso sta al centro di tutto il dramma», consentendo, in questo modo, che «il quinto stato, quello degli schiavi, domin[i] la scena»[2].
La storia della letteratura mondiale è stata, nelle sue articolazioni, una storia tormentata in cui, da un punto di vista estetico, il paradigma Euripide (che possiamo designare come inclusivo) ha tentato di farsi strada in tutti i modi contro il paradigma Aristofane (esclusivo), il cui dominio incontrastato verrà messo fortemente in discussione soltanto dallo scoppio della Rivoluzione Francese, prima, e della Rivoluzione d’Ottobre, poi. Non è un caso che, nel tessere le lodi di Tolstoj, in un articolo del 1910, Lenin annovera, fra i meriti del romanziere russo, proprio la sua attitudine ad oltrepassare quella selettività sentimentale che contraddistingueva l’opera di molti scrittori precedenti, ciò che gli avrebbe permesso di «tradurre con forza notevole lo stato d’animo di larghi strati della popolazione, oppressi dal regime attuale, descrivere la loro situazione, esprimere il loro spontaneo sentimento d’indignazione e di protesta»[3]. E nei Quaderni del carcere, sono proprio le opere di Tolstoj ad essere evocate, da Gramsci, in contrapposizione alle barriere sociali che, nei Promessi sposi, tengono imprigionato l’animo del Manzoni:
Nel Tolstoi è caratteristico appunto che la sapienza ingenua e istintiva del popolo, enunciata anche con una parola casuale, faccia la luce e determini una crisi nella coscienza dell’uomo colto. Questo anzi è caratteristico della religione di Tolstoi che intende l’evangelo «democraticamente», cioè secondo il suo spirito originario e originale. Il Manzoni invece ha subito la Controriforma, il suo cristianesimo è gesuitismo. E il Faggi nota che «nei Promessi Sposi sono gli spiriti superiori come il padre Cristoforo e il Card. Borromeo che agiscono sugli inferiori e sanno sempre trovare per loro la parola che illumina e guida». Bisognerebbe ancora notare che nei Promessi Sposi non c’è personaggio di condizione inferiore che non sia «preso in giro»: da don Abbondio, a fra Galdino, al sarto, a Gervasio, ad Agnese, a Renzo, a Lucia: per lo meno essi sono rappresentati come esseri meschini, senza vita interiore. Vita interiore hanno solo i signori: fra Cristoforo, il Borromeo, l’Innominato. Perpetua, secondo Don Abbondio, aveva detto presso a poco ciò che dice il card. Borromeo, ma è notevole come questo spunto sia oggetto di comico. In realtà anche nel Manzoni si potrebbero trovare voli tracce di Brescianismo (così il fatto che il parere di Renzo sul valore del voto di verginità di Lucia coincide col parere di padre Cristoforo, o l’importanza che ha la frase di Lucia nel turbare l’Innominato e nel determinarne la crisi morale, sono di carattere ben diverso da quello che ha in Tolstoi l’apporto del popolo come sorgente di vita morale e religiosa)[4].
Questa distanza sentimentale tra gli scrittori e il popolo che in Italia impronta la cultura in modo più marcato che altrove (donde la tendenza della popolazione italiana a prediligere i romanzi stranieri), se da un lato viene da Gramsci attribuita al carattere cosmopolita, dunque non nazionale-popolare (dovuto all’esser stata Roma sede della Chiesa e dell’Impero), della nostra intellettualità, dall’altro mostra legami con questioni di carattere linguistico: l’italiano si configura, a ben vedere, come una lingua deficitaria, suscettibile di alimentarsi «poco, nel suo sviluppo, dalla lingua popolare che non esiste (eccetto in Toscana)» poiché «esistono i dialetti»[5]. In questo senso, l’italiano costituisce una lingua «sempre un po’ fossilizzata e paludata e quando vuol essere famigliare, si frange in tanti riflessi dialettali». Ne consegue che, se per un verso nessun dialetto può costituire una lingua nazionale, una vera e propria lingua nazionale non lo è neppure l’italiano, in quanto rappresenta un codice lontano dai sentimenti del popolo-nazione. A conti fatti, conclude Gramsci, «l’italiano, in gran parte, è un esperanto, cioè una lingua parziale»[6].
È vero, dagli anni in cui queste riflessioni vengono elaborate la lingua italiana ha subito un profondo cambiamento e lo sviluppo del mezzo televisivo ha svolto un ruolo di fondamentale importanza nella diffusione della lingua nazionale anche presso i ceti sociali meno abbienti. Nondimeno, a tutt’oggi, l’italiano circolante costituisce una lingua «povera di livelli diversificati, proprio perché in una versione pluristilistica è ben lungi ancora dall’essere patrimonio comune»[7]. Si tratta invero di un idioma cui competono un impiego e un prestigio circoscritti, incapace com’è «di essere per la maggior parte dei parlanti una lingua d’uso al punto da consentire il passaggio fluido e competente da un livello all’altro»[8], cosicché, tutte quelle comunità di parlanti italiane che «sono originariamente dialettofoni», come lo è ad esempio «la maggioranza dei parlanti veneti», percepisce di fatto «l’italiano come “they code”»[9].
Di qui il ricorso al dialetto quale strumento in grado di trasmettere un universo sentimentale altrimenti lasciato in sordina. Ed è con questo strumento che Giannini si appresta a perlustrare il mondo dei cantieri, dei mercati, delle periferie nella loro vita atomizzata. Con uno stile diretto e asciutto, incline a ridurre al massimo la distanza tra le parole e le cose (secondo una tradizione che, per quanto concerne la poesia in lingua italiana, aveva trovato in Saba il suo più illustre esponente), sulle influenze di Scataglini e del primo Franco Loi (quello di Strolegh soprattutto), Giannini ci restituisce, con i propri versi, squarci di mondi dimenticati da Dio, o relegati entro un passato artistico ormai uscito di scena. E dire che quei mondi, lungi dall’averci abbandonato seguendo il cammino delle loro narrazioni, continuano ad affollare come non mai la vita odierna: gli operai al lavoro (Ad uno ad uno dai bughi oscuri sorte, / pare l’insetti neri de la morte. […] / Pare le bestie tonte de calura, / parene i morti che non cià ventura), j omini del mare, li mattatori, i macchinisti, i murator[i], el garzo’ che porta el baccalà, la madre contadina, e poi i libici, i siriani , j ‘racheni (lo sguardo lasco, / fuggiti dalle bombe de j imperialisti, / da Bagdad, Tripoli, Damasco), gli Yemeniti, i nordafricani (ognuno trafitto da j americani), la ragazza marocchina (questuante dalle otto de mattina, / che smonta dal suo turno all’una e mezzo, / mentre passa le buste d’olio, de carne e de farina, / coi ciuffi fòri de sedano e disprezzo), le badanti peruviane, e poi albanesi e rumeni (Tra le carrucole e la calcina / cùre, che l’aspetta l’Adriana, / un ragazzotto in canottiera, / de Tirana. / Un altro, un rumeno, / stracco, che è sera, / comincia a monda’ la betoniera) e….E quando in paese / s’è saputo / d’un elettricista / brugiato n’te le prese, / s’è messi el còre in pace: / era un senegalese.
Questo, assieme a quello più intimo e affettivo del poeta, l’orizzonte antropologico che gremisce i versi del volume.
In mezzo a un tale pullular di vite quindi, sotto l’odore / fetente / del baccalà, tra vecchie che sparge…veleno contro el mondo e immagini a torno le stazioni di disgraziati che stendene i cartoni, tra el puzzo guasto dei cassonetti e la pozza giallo scura dell’urina, tra la sveja al mattino e j urlacci dei portuali, tra silenziose urla / e morti bianche ‘nte la via si consumano, lenti ed angosciosi, i giorni del poeta, rotti tra due dimensioni, quella politica e quella intimista, che fanno tra loro il paio e costruiscono l’identità narrante.
Vediamo di capirci: la lingua che scandisce i versi, nelle loro rime baciate, alternate, incrociate e incatenate, non è soltanto dialettale, ma un intervallarsi, un amalgamarsi di dialetto e italiano. Questo impasto, non va inteso in senso soltanto stilistico, ma anche prospettico. Il sentimento è popolare (dialetto) ma la coscienza è nazionale (italiano). Il variegato universo umano che i versi ci pongono dinanzi, non ci appare nella sua immediatezza, nella sua dissennata caoticità, ma si dispiega, sia pur in modo magmatico, entro assi che ne avvicinano l’animo in quanto ne orientano la comprensione. E questo avviene contrastando nella pratica quella convinzione estetica (fattasi strada negli ultimi decenni, nonostante Brecht) secondo cui la politica costituisce lo scoglio contro cui arte e poesia sono destinate ad infrangersi: Cianne levato pure l’articolo diciotto, / ‘che non je basta mai: / alza la testa solo j operai (Ondeggia sordomuta); El ragazzi’, a tempo determinato, / lascia dopo do’ mesi l’officina: / ritorna ai stenti che l’ha segnato. / Je strigne la mano, ipocrita, el padrò: / e, stranamente, l’operaietto ghigna: / ha da torna’, baffo’. (Ha da tornà, baffo’); Così è accaduto un fatto strano, / che la dice longa de dove ‘andamo. / C’è un giardiniere marocchino / che da sett’anni cura el giardino, / de tutti noi, del condominio. / Quando stamane ha citofonato / ( zappa e semi’, per cura’ el prato) / la porta in faccia janne blindato. / È un palazzo de lavoratori: / non è bastato per ricorda’ i valori. / S’è alzata un’onda bianca identitaria: / ‘na diga imperialista e immunitaria. (La diga imperialista e immunitaria); vie’ da Belgrado, è mutilato, / brugiato fino aj occhi dalla NATO (Sedano e disprezzo).
Accanto a questa dimensione politica che distingue il poeta, in fatto di coscienza, dal mondo antropologico esplorato, subentra anche una dimensione intimista che concorre a scolpire l’identità dell’io. È qui che si insinuano temi della tradizione cristiano-romantica e poi decadente: la vecchiaia, l’eros, la malattia, la demenza, la morte. Questo topos letterario, che agli occhi di un marxista ortodosso potrebbe apparire come un cedimento artistico a campi magnetici avversari, assolve in questo volume la funzione di un valore aggiunto, in quanto non scisso dall’Intero. Dimensione politica e dimensione esistenziale si configurano, invero, quali particolari esiti di una sconfitta storica: Ade’ semo sconfitti, / e ogni minuto è duro (Come quando su pe’ monti). Una sconfitta che sembra ripercuotersi, con beffardo cinismo, sugli stessi rapporti interpersonali, lacerati dal peso sempre più opprimente della fragilità e dell’insicurezza: Semo ‘mutiti, / vòti de mente: / brugiati i riti, / tornamo al niente (L’ogne cinque del pavo’). Dilagano allora solitudine e disperazione: L’ho visto solo / porta’ le mani ‘ntei capelli, / come quando / -entrati ‘nte le case- / infuria i pipistrelli (Via Ugo Betti). Ma, dicevamo, sotto il sentimento popolare, la coscienza resta nazionale, ed impedisce di attribuire al caso o alla sfortuna ciò che appare sotto una luce fin troppo chiara: Ma sotto al nero dei capelli che se stigne / -cola bitume dalla sua mente – / el lercio che cià in testa è trasparente: / j’arbolle ‘ntel cervello, / come fagioli ‘nte le pigne (Sale la camionetta). È questa chiarezza, invero, che tiene a freno le illusioni: Ma io ciò un male / de cui, più, non me vanto: / me giro, e m’arsale el disicanto (Re Mida). Nelle poesie che seguono, il cerchio che teneva unite dimensione politica e dimensione esistenziale, quel cerchio in cui la degenerazione antropologica e relazionale appare come il frutto di un degrado storico-politico, rendendo persino la vecchiaia, le separazioni, la malattia e la stessa idea di morte, infinitamente più angoscianti e dolorosi, quel cerchio giunge a chiudersi con versi piuttosto inequivocabili: Se poi, correndo a sorte, senti il telegiornale, da qualche appartamento giu’ pel Viale / e ‘scolti la bibisi, e ‘scolti el telesur, capisci che il mondo intero è alla malora / e non solo la Dora, con la statua che galleggia, al porto, de Cavour. / Così te chiederai: e ade’ cu’ famo? Che vita c’è dopo ‘sta vita? Che vòto strano… / E anch’io, Licetta mia, cosa faria senza di te? Dov’è che andria? (Se un giorno s’alza el mare); È stato un comandante partigiano, un omo, un leo’. / Nel posso vede, adè – eroe della Liberazio’ – / solo, spolpato, sciuccà i calzetti ‘ntel termosifo’. / Semo materialisti: non ce fa tristi / el tempo che ce mette ‘ntun cantone: / è che per no’ s’è spenta la rivoluzione (Ha operto le serrande); Ma ando’ per tutti male: fu ‘na sconfitta: / la rivoluziò, come un Liala vecchio, / s’inscatolo’ in soffitta. / Chi , perso il tempo, fa il cameriere; / chi scorda Allende e se rimette el fard: / Maria se perde ‘nte i boulevard. / Che è andata male a tutti non consola: / el sogno morto tel porti drento te, da sola. / L’ arcoje la sorella alla stazio’, / la tiene in braccio, ‘na deposizio’. (Maria) La sconfitta della rivoluzione ha lasciato il posto ad un triste scenario, ad un degrado sociale ed umano, entro il quale il poeta avverte un crescente senso di inettitudine e inadeguatezza: come fossi un Cosini anconeta’, / un Zeno del Pia’, de Svevo, / che non je la fa a smette de fuma’, / e manco a mori’, o a campa’ (Scrivo s’un bijetti’); Me sento, insomma, sempre fòri posto: / come le vecchie col majio’, d’agosto (Grazie che m’el chiedi).
Ad accompagnare, più che la descrizione, la narrazione poetica di questo mondo (la griglia verbale sembra più folta di quella aggettivale), troviamo una particolare comicità, una sorta di ironia dal sapore amaro che, verso per verso, scandisce ogni componimento. Questa costituisce, in genere, la cifra attitudinale dei mondi in decomposizione: se Aristofane esprime i sintomi della decadenza del mondo ellenico e Cervantes quelli della dissoluzione della cavalleria, l’ironia amara di Giannini, tracciate naturalmente le dovute proporzioni, esprime qui i segni dello sgretolamento del mondo operaio, inteso questo nel senso più ampio del termine. Abbiamo quindi il ripresentarsi dei tratti più caratteristici del comico, sintetizzati in questi termini da Hegel: la realtà viene portata a rappresentazione nella stoltezza stessa della sua corruzione in modo siffatto, che essa si distrugge in se stessa, affinché, appunto in questa autodistruzione di ciò che è giusto, il vero possa per riflesso mostrarsi come potenza salda, che permane, e non venga lasciata al lato della stoltezza e della irrazionalità la forza di un’opposizione diretta contro ciò che è in sé vero[10].
Ma anche, e forse più specificamente, quelli della satira:
Un nobile spirito, un animo virtuoso a cui rimanga negata la realizzazione della sua coscienza in un mondo di vizio e stoltezza, si volge con appassionata indignazione o sottile arguzia e gelida amarezza contro l’esistenza che gli sta dinanzi, ridicolizzando o adirandosi contro il mondo che direttamente contraddice alle sue idee di virtù e verità[11].
Il sopravvento dell’ironia, a ben vedere, nasconde un volto nichilista (come, d’altro canto, si riscontra anche in Pirandello) che non riesce più a trovare nel mondo reale l’elemento del sublime. Soltanto un verso sfugge, in questo volume, al vortice amaro del sogghigno, e alla tagliola della dissacrazione: quel tutti insieme mettene paura del primo componimento, annunciato dall’avversativa ma che oppone una pars construens carica di valore alla pars destruens dei versi precedenti, pregni di “appassionata indignazione” e “gelida amarezza”. Per il resto dei componimenti, il sublime sembra accantonato. Domina piuttosto l’ironia, come dominano disperazione e sconforto. Ma, possiamo domandarci, sono, questi, sentimenti rivoluzionari? O, detto in altri termini (quelli che qui, ora, sembrano più interessarci) sono sentimenti così prolifici ed efficaci da un punto di vista artistico? Nello scritto su Tolstoj che abbiamo precedentemente evocato, se da un lato veniamo messi in guardia contro le illusioni volontaristiche e i facili entusiasmi, dall’altra Lenin ci rammenta che «la disperazione è propria delle classi agonizzanti», che «la disperazione è propria di coloro che non comprendono le cause del male, non vedono via d’uscita e sono incapaci di lottare»[12]. Questo enunciato assume un valore non soltanto storico-politico, ma anche estetico. Se la letteratura raggiunge i propri risultati migliori quando non rincorre sogni, chimere astratte, o capricci individuali, quando non imprigiona le proprie sillabe negli argini degli interni soggettivi o dei funambolismi narcisisti, ma riesce a calarle nelle pieghe e nelle piaghe della realtà vivente, quando non segue i voli pindarici compiuti dalle ragioni del cuore e della mente, ma sa volgere lo sguardo alle ben più complesse ragioni del mondo (G. Debenedetti), quando diventa in grado di far parlare la vita stessa anziché il nostro spirito commosso o sconcertato dinanzi all’immagine della vita, allora questa letteratura dovrà anche ricordarsi che mondo, vita, realtà, non costituiscono un manto uniforme, ma, presi nella loro interezza, sono dialettica, e che pertanto, ancorché in spazi sensibilmente ridotti e talvolta pressoché impercettibili, restano intatte, tra mille difficoltà, le forme del valore e, con esse, i tratti del sublime.
Resti ben chiaro, ad ogni modo, che l’ironia di cui fa sfoggio Giannini, non sottende una visione dell’arte e della poesia come di un gioco frivolo: la sua parola non cede alle facili lusinghe dell’allegoria (come avviene in una buona parte della letteratura postmoderna), dove «la realtà…vi è necessariamente guasta e mutilata», giacché in essa «non ha vita propria, o per dir meglio non ha vita alcuna» essendo «l’interesse» riposto «tutto nel figurato, nel pensiero»[13]; e dove ci si accinge a «distruggere le forme di oggettività esistenti, quelle immediate e quelle ampiamente mediate»[14]. Al contrario, la poesia di Giannini, mostra di nutrire un’attrazione verso la vita reale troppo forte per giungere a decomporne le sembianze: quasi avvertisse, in modo istintivo, che ogni qualvolta le forme artistiche cominciano ad estraniarsi dall’uomo, vi è sempre un qualcosa dell’uomo (e dunque della realtà) che viene perduto. Sembrano nascondere, i versi di questi componimenti, un suggerimento, un invito sincero affinché la letteratura, per usare le parole di Lukács, si impegni a «scoprire, proclamare o smascherare i…nessi reali» del mondo, «di fatto latenti», anziché limitarsi a «negare la realtà» distruggendola «nel campo estetico»[15].
A fronte di quanto detto sin qui e del clima culturale imperante sui i nostri orizzonti esistenziali, si ritiene che i testi di questo libello possano fornire un contributo quanto mai opportuno per un rinnovamento della poesia italiana, rimasta intrappolata, ai giorni nostri, in una condizione di preoccupante aridità spirituale.
- [1]Aristofane, Rane, in Id., Le Commedie, Newton Compton, Roma 2008, p. 875.
- [2]F. Nietzsche, Socrate e la tragedia, in Id., Opere 1870-1881, Newton Compton, Roma 1993, pp. 50-51.
- [3]Lenin, Scritti su Tolstoj, Medusa, Milano 2017, pp. 32-33.
- [4]A. Gramsci, Quaderni del carcere, Einaudi, Torino 2001, Q 3, 149.
- [5]Ivi., Q 6, § 94.
- [6]Ivi., Q 3 § 73.
- [7]N. Prantera e M. Maddalon, Tendenze del repertorio italiano. Ancora sul mistilinguismo: http://clt.unical.it/Doc_Varie/Ricerche/Dialettologia/Mistilinguismo.pdf, p. 4.
- [8]Ivi., p. 7.
- [9]Ivi., p. 19.
- [10]Hegel, Estetica, Einaudi, Torino 1997, p. 575.
- [11]Ivi, p. 577.
- [12]Lenin, cit., pp. 47-48.
- [13]F. De Sanctis, Storia della letteratura italiana, introduzione di René Wellek, Bur, Milano 2006, p. 230.
- [14]G. Lukács, Allegoria e simbolo, in Id., Estetica, Einaudi, Torino 1973, p. 832.
- [15]Ivi, pp. 832-833.
SINOSSI EDITORIALE
La poesia è una forma eretica del linguaggio. In questo senso essa è, sempre, dialettale. La forzatura estetica serve a fissare la cornice entro la quale si muovono i versi di Fosco Giannini. La scelta del “dialetto” è solamente funzionale alla resa stilistica-musicale-contenutistica, senza nessuna concessione alla macchietta vernacolare. A partire da ciò la poesia di Giannini – che si è costituita attraverso un lunghissimo lavoro sul linguaggio e la ricerca – scansa scientemente e anche violentemente il popolare farsesco puntando all’universalità: il dialetto come poesia totale, evocazione “d’altro”. Il linguaggio della “totalità” poetica permette a Giannini di scendere nei “cantieri, nei mercati, nei quartieri scalcinati” tra il proletariato e il sottoproletariato ( ecco il senso di “ Poesie in forma di popolo”), senza per questo pagare il dazio del populismo o di certi imbarazzanti esiti vernacolari. D’altra parte è Giannini stesso a dichiararlo: “Una pletora di poeti piccolo borghesi ha scritto in “dialetto” credendo di utilizzare, solo per questo, il linguaggio del popolo. Solo che questa attribuzione era falsa e la poesia che ne risultava era solo la brutta idea che quella piccola borghesia aveva del popolo”.
“POESIE IN FORMA DI POPOLO” DI FOSCO GIANNINI CASA EDITRICE “LA CITTA’ DEL SOLE”- PAGINE 188- EURO 10.00
CHI VOLESSE ORDINARE IL LIBRO ON LINE PUO’ RICHIEDERE INFORMAZIONI ALL’INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA:
posta@diestlibri.it 0118981164 DIEST Distribuzioni Torino