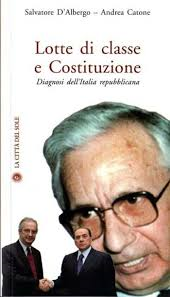di Ufficio Stampa. Riceviamo e pubblichiamo un ricordo del Compagno Salvatore D’Albergo, pur non condividendone le conclusioni. Riteniamo doveroso ricordare la figura dell’intellettuale e crediamo che questa lettura possa rappresentare uno spunto di riflessione sull’analisi dello scioglimento del PCI e delle sue conseguenze e, al contempo, per noi del PCI, un’altra prova della necessità della ricomposizione e ricostruzione di una forza comunista moderna, che riprenda la migliore tradizione di quella storia.
Ricorre in questi giorni il terzo anniversario dalla scomparsa di Salvatore D’Albergo, forse l’ultimo degli intellettuali organici coerentemente gramsciani presenti nella sinistra comunista italiana.
Per ricordarlo ho provato a tirar giù, soprattutto sulla base dell’esperienza personale, una nota che vi allego e riguardante la vicenda degli “Autoconvocati Comunisti” cui D’Albergo non solo aderì ma che, anzi promosse, svolgendovi un compito dirigente rivelatosi di grande spessore politico e culturale.
Nel testo si troveranno sicuramente lacune e imprecisioni delle quali prego di scusarmi: l’intento non è soltanto quello di rievocare il passato ma di fissare alcuni punti sui quali ancora oggi sarebbe bene puntare la nostra attenzione militante.Tra il 1987 ed il 1991 si sviluppò, a livello nazionale, il movimento degli “Autoconvocati Comunisti”: un gruppo di compagne e compagni, iscritti e non iscritti al PCI, che sulla base di analisi e valutazioni riguardanti l’evidente declino del Partito tentarono, con una serie di iniziative per l’appunto “autoconvocate” di sollevare i temi di fondo della presenza dei comunisti in Italia e di intervenire propositivamente nella vita del partito stesso.
Furono organizzati convegni, redatti documenti, effettuati interventi in importanti assise, sviluppato con Democrazia Proletaria , il Movimento Politico per l’Alternativa (che raccoglieva una parte degli ex-pduppini non confluiti nel PCI) e la Sinistra Indipendente una importante attività editoriale, attraverso il mensile “A Sinistra” che, in quegli anni, ebbe un ruolo non secondario a livello pubblicistico nella sinistra italiana ( facevano parte del comitato editoriale: Giorgio Cortellessa, Salvatore D’Albergo, Giulio Girardi, Domenico Jervolino, Lidia Menapace, Elio Veltri).
Il movimento degli “autoconvocati comunisti” si avviò, all’indomani della sconfitta elettorale subita dal PCI nel 1987, su due filoni: a Roma, per iniziativa di un gruppo di giovani ricercatori del Centro di Riforma dello Stato e di sindacalisti della CGIL, e al Nord su iniziativa di chi sta scrivendo queste note, del professor Salvatore D’Albergo dell’Università di Pisa e di Angelo Ruggeri, della segreteria regionale lombarda della CGIL.
I due gruppi si unificarono attraverso la pubblicazione di una “lettera aperta” al Comitato centrale del PCI , apparsa sul “Manifesto” il 24 Novembre 1987.
Fu in quell’occasione che Carmine Fotia coniò il termine “autoconvocati comunisti”, mentre sul “Corriere della Sera” Giuliano Ferrara adombrò l’idea di una “manovra” della corrente ingraiana (che in realtà era contraria all’iniziativa: soltanto, più tardi, considerato il successo di “A Sinistra” molti esponenti della sinistra PCI decisero di scrivere e collaborare, in particolare Sergio Garavini e Lucio Magri, oltre a diversi giornalisti del Manifesto come Aldo Garzia).
Riprendo queste notizie dal volume ” La parola al Conflitto : esperienze e proposte degli autoconvocati del PCI 1987-1990″ edito da Datanews nel dicembre 1990, e redatto da Fabrizio Clementi, capo ufficio studi dell’ANCI e Fabio Giovannini, ricercatore del CRS che erano stati tra i principali animatori del movimento.
L’esperienza degli “autoconvocati” si esaurì al momento dell’ingresso di Democrazia Proletaria in Rifondazione Comunista: si svolse, nel Dicembre del 1990, un confronto in una sala di palazzo Valentini a Roma, tra tutte le “anime” che avrebbero dovuto comporre il nuovo Partito e risultò evidente come ci si trovasse molto al di sotto della soglia minima per realizzare coerentemente una impresa che contenesse, sul piano organizzativo e su quello dei contenuti, le istanze di rinnovamento che gli “autoconvocati” avevano portato avanti in quegli anni.
Non vi fu, quindi, una adesione collettiva al nuovo partito, come pure gli esponenti di DP (in particolare Giovanni Russo Spena e Domenico Jervolino) auspicavano, ma alcune adesioni individuali, in particolare quella di Salvatore d’Albergo e del gruppo di Parma (Parma era stata la sede delle prime iniziative pubbliche del gruppo).
Tra l’altro è necessario ricordare come, nel momento della battaglia politica svoltasi attorno alla proposta di scioglimento del PCI, il movimento degli “autoconvocati” avesse tentato di presentare una propria mozione, proprio per riassumere significativamente in un contesto così importante, i contenuti portati avanti in quel periodo.
Questa possibilità fu vanificata da pastoie burocratiche (ci fu un tempestoso incontro, alle Botteghe Oscure, con Fassino) e alla fine si dovette ripiegare su di un testo di mozione congressuale collegata alla mozione n.2 ( Natta – Ingrao).
Quali erano, comunque, i contenuti che gli autoconvocati portarono avanti in quegli anni?
Prendo a prestito una occasione, quella di un Seminario Nazionale svoltosi nell’Ottobre del 1988 alla sala dell’Arancio a Roma, nel corso del quale mi capitò la ventura di svolgere la relazione introduttiva (intervennero anche Fabrizio Clementi,Salvatore D’Albergo, Giuseppe De Santis, Franco Ferrari, Fabio Giovannini, Vittorio Parola, Antonio Peduzzi e Angelo Ruggeri oltre ad esponenti del PCI e di DP) per riassumere di seguito quel testo, credo esemplificativo della realtà politica del gruppo:
“La crisi del PCI sta assumendo un peso enorme all’interno della vicenda politica del nostro Paese. Siamo al punto in cui si rende plausibile una previsione di cancellazione di quella “anomalia Italiana” che proprio la realtà del Partito Comunista” ha rappresentato nella storia degli ultimi decenni.
E’ così cresciuta, all’interno del gruppo dirigente del PCI, l’idea di arrivare a quello che è stato definito il “nuovo corso”: un “nuovo corso” che appare contrassegnato dall’ansia di individuare, anche sul piano teorico, la nuova qualità delle contraddizioni emergenti nella società moderna.
La prima valutazione che può essere compiuta intorno alla ricerca e alle proposte presentate fino a questo punto come piattaforma per il prossimo congresso del PCI (che si sarebbe poi svolto nel Marzo del 1989, con la conferma di Occhetto alla segreteria: ndr) non può essere positiva.
Il tipo di risposta che viene offerta per contrastare l’offensiva neo-conservatrice ancora in corso non appare coerente: non si delinea una scansione di priorità; stentano ad emergere i terreni di lotta su cui costruire una prospettiva strategica di inversione di tendenza.
La giusta intuizione della complessità dei mutamenti in atto non viene così collegata ad una analisi convincente circa il rinnovarsi delle dimensioni concrete della lotta di classe: una nozione, quella di “lotta di classe” che non può essere abbandonata, ma che deve invece essere allargata oltre i tradizionali confini di riferimento.
I temi che normalmente vengono citati quando si parla di nuova qualità delle contraddizioni sono ben noti, ed è appena il caso di citarli: ambiente, differenza di sesso, rapporto tra il Nord ed il Sud del mondo, mercificazione della cultura, ideologizzazione di mezzi di comunicazione di massa.
Il punto su cui si registra il limite più evidente all’interno delle indicazioni offerte dal “nuovo corso” comunista è proprio questo: i temi appena citati costituiscono una sorta di indice dei beni immateriali non contrattabili, che si intrecciano direttamente con la contraddizione “storica” tra capitale e lavoro.
Non può allora diventare possibile, come si adombra nei documenti precongressuali recentemente discussi dal CC del PCI, trasformare questi beni immateriali nell’oggetto di un nuovo compromesso, tutto spostato dalla parte dei meccanismi della rappresentanza politica formale e di una piena ripresa di intangibile autorità del “sistema di impresa”.
I “nuovi beni” si troverebbero così nuovamente rinchiusi all’interno di una logica tale da perpetuare quella prospettiva, già rivelatasi storicamente perdente di “patto tra i produttori” che rappresenta ancora un punto di negativa continuità nell’elaborazione del PCI.
L’oppressione determinata dalla trasversalità delle forme di sfruttamento rende invece inscindibile l’intreccio di contraddizioni che stiamo vivendo e pone per intero la grande questione del rapporto tra individuale e collettivo; tra privato e sociale; tra semplice “diritto di cittadinanza” ed “interesse generale”.
Non si può parlare di “democrazia come via al socialismo” senza misurare con chiarezza il campo dello scontro che, proprio sul tema della democrazia si va proponendo in molte parti dell’Occidente ed in particolare in Italia.
Si tratta, infatti, di scegliere tra due strade:
a) quella (apparentemente vincente) della politica vissuta come merce di scambio tra comparti rigidamente separati dove la società di spezzetta in corporazioni e si nutre di fondamentalismi, lasciando il “manovratore” del tutto indisturbato;
b) quella, certo più difficile, di ritrovare il senso di una “politica forte” dove i comunisti misurano per intero le proprie ragioni e le proprie capacità di tenere assieme un conflitto sociale le cui forme vanno ben oltre i confini tradizionali del sistema produttivo con obiettivi legati ad un progetto di radicale trasformazione dell’esistente.
Il “nuovo corso” del PCI non arriva a definire il terreno concreto delle istanze di cambiamento su cui far intervenire le grandi masse proprio perché, sotto il peso della controffensiva conservatrice, sviluppatasi in questi anni, anche lo stessi partito comunista ha oscillato paurosamente verso la “politica debole”: la politica, cioè, concepita soltanto come schermo; piegata ad apparenti ragioni di realismo e di pragmatismo.
In questa realtà la politica viene intesa nel senso di un mero supporto al dominio incontrastato dei più forti; strumento della riduzione della classe a “popolo minuto”.
Nel documento presentato in questi giorni da Occhetto al CC non esiste una vera inversione di rotta: la democrazia viene ancora ridotta ad essere concepita quale strumento regolativo di uno scontro tra poteri diseguali.
A questo modo non si comprende appieno che il conflitto (una volta accettate acriticamente le condizioni materiali imposte dall’esistente) si riduce a forme di scontro di tipo essenzialmente elettoralistico e corporativo.
Il problema sta dunque, almeno dal mio punto di vista, nel riportare proprio il tema del conflitto ad una dimensione di eguaglianza, sul piano dell’espressione dei valori: all’ideologismo rozzo dell’avversario va contrapposta nuova teoria; nuova capacità di proporre una idea diversa dello sviluppo sociale.
Il tema del rapporto tra allargamento della democrazia e nuove contraddizioni sociali non si risolve allora proponendo una soggettività politica semplicisticamente aderente a “tutte le pieghe della società” e ridotta, alla fine, ad essere mallevadrice di una correzione dell’ordine costituito orientata verso una generica “giustizia sociale”.
Occorre, invece, avere il coraggio di proporre una alternativa di valori ridefinendo sicuramente la centralità della contraddizione tra capitale e lavoro, ma misurando attorno a questa necessità di ridefinizione di un progetto di “rete”; di un nuovo intreccio tra sociale e politico, che a partire dal sociale, fa crescere una opposizione antagonista che punta a riunificare un blocco a partire dalla lotta.
Quello della “lotta” non può risultare un generico e ritualistico richiamo: si tratta, infatti, di affrontare, al livello delle grandi masse, i nodi che oggi reggono la formidabile interconnessione che si è realizzata tra struttura e sovrastruttura, ad opera dei ceti dominanti.
Gli elementi concreti di cui può alimentarsi questa alternativa possono essere così riassunti:
1 una visione dei grandi temi internazionali che parta sì dalla giusta intuizione dell’interdipendenza ormai stabilitasi a livello planetario, tra i diversi processi di concentrazione del potere militare, scientifico, economico, politico, ma che pervenga a porre il tema della costruzione di un nuovo campo progressista, tale da consentire ad un gran numero di stati nazionali di compiere concreti atti unilaterali per consentire di giungere ad uno scongelamento dei blocchi e di porre, sul serio, la centralità del rapporto Nord-Sud. La costruzione di un nuovo campo progressista non allineato alle alleanze militari date (beninteso senza “stati guida” e “modelli di socialismo” da imitare) può essere indicata come obiettivo per un inveramento di quella idea di “terza via”, che costituisce ancora un punto alto di intuizione e di proposta politica. Inoltre, proprio una nuova dimensione dell’internazionalismo orientata in questa direzione, può rappresentare lo stimolo decisivo per recuperare una capacità di mobilitazione attorno ai fondamentali valori espressi, in questi anni, dai movimenti ecologisti e pacifisti; il tema dell’autonomia europea,ad esempio, passa per la gran parte attraverso la concretizzazione di una problematica di questo tipo.
2 una collocazione dei temi riguardanti il quadro politico italiano misurata da una realistica analisi del blocco moderato che, in questa fase, sta sostenendo un ulteriore inasprimento dell’offensiva neo-conservatrice.
Un blocco moderato che trova le sue immediate espressioni politiche nei gruppi dirigenti di Psi e Dc.
Anche su questo argomento le proposte di “democrazia economica”; di ridefinizione dello stato sociale; di revisione istituzionale che vengono proposti nel documento pre-congressuale del PCI per contrastare l’avversario appaiono lungi dal definire quel quadro di “opposizione per l’alternativa” che risulterebbe necessario.
L’obiettivo delle forze dominanti rimane quello di stabilire, attraverso l’introduzione nel sistema politico italiano di uno schema di “bipolarismo debole” un rapporto diretto tra autonomia del politico e definitiva corporativizzazione della società.
Il traguardo finale rimane quello del rapporto tra politica e società; di realizzazione di un progetto di vera e propria spossessione della militanza di massa.
Gli esempi da fare risultano fin troppo facili: voto segreto, diritto di sciopero, profilarsi, sempre più preciso, dell’ipotesi di repubblica presidenziale.
Alla diminuzione di forza dell’area comunista, dovrebbe dunque corrispondere un ribaltamento della costituzione, portando il sociale a dipendere dalle istituzioni, attraverso una astratta esaltazione della governabilità.
Il gruppo dirigente del PCI non appare ancora pienamente conscio di questi pericoli: slegare come fa Occhetto i rischi di istituzionalizzazione del Sindacato dalla necessità di contrastare fino in fondo la limitazione del diritto di sciopero costituisce un errore proprio perché dimostra l’incapacità di comprendere come il terreno della possibilità di conflitto, patrimonio del movimento operaio, sia quello su cui si tenta di introdurre i punti più cogenti della riforma istituzionale nel senso di una limitazione, per tutti, dei diritti di libertà,
Inoltre l’ipotesi di cogestione dell’economia, che pure si adombra nella più volte citata bozza pre-congressuale, risulta davvero troppo debole rispetto alla formidabile concentrazione del potere operante,oggi come oggi, proprio in funzione dell’enormità di interessi che vi si riconoscono e che il grande capitale intende imporre all’intera società.
La nostra discussione deve allora concentrarsi su questo punto: come si superano le ambiguità, i limiti, gli impedimenti che ancora pesano fortemente sulle possibilità di intervento politico delle forze potenzialmente alternative?
Si tratta, almeno per mia opinione, di preparare una lunga e articolata fase di lotta, nel corso della quale puntare alla ramificazione all’interno del senso comune di massa, di una vera e propria controtendenza al riguardo dell’apparato egemonico costruito dall’avversario.
E’ il caso allora di guardare fino in fondo al nostro modo di essere comunisti; sulla base di quali spinte ideali; per ciò che concretamente i comunisti rappresentano nella vita di tutti i giorni.
Si deve trovare una coerenza intima e soggettiva, eppure al tempo stesso universale, tale da contraddistinguere, ancora una volta, una diversità di militanza che non può esistere senza avere, davanti a sé, l’orizzonte del marxiano “abolire lo stato delle cose presenti”. “
Fin qui l’intervento alla Sala dell’Arancio.
L’iniziativa degli “Autoconvocati Comunisti” ovviamente risentì, e in seguito si esaurì, all’interno della vicenda seguita alla cosiddetta “svolta della Bolognina” e successivamente alla fondazione di Rifondazione Comunista.
Concludo allora questo memoria quindi riferendomi nel dettaglio al seminario svolto ad Arco di Trento nell’ultima settimana di settembre 1990.
Il Seminario di Arco, (settembre 1990) sancì la spaccatura definitiva della sinistra comunista in Italia e la chiusura di quella esperienza politica che poteva ben essere fatta risalire al gruppo della sezione socialista di Torino raccolto attorno all’ “Ordine Nuovo” alla fine degli anni’10, poi, via, via, nelle posizioni di Ingrao all’XI Congresso, alla vicenda del “Manifesto”e poi del PdUP, all’ultimo Berlinguer quello dell’alternativa democratica, fino – appunto – alla mozione del “NO” allo scioglimento del PCI,
In quella sala di Arco ( ero presente, delegato dagli Autoconvocati con Fabio Giovannini e Fabrizio Clementi) c’erano i rappresentanti di DP e del Manifesto assieme al gruppo dirigente della mozione del “NO”.
Dopo la relazione di Magri, gli interventi opposti di Cossutta e di Ingrao (con la celebre metafora del “gorgo”) chiusero ogni possibilità di dibattito politico, presentando la realtà di una divaricazione non superabile.
In quell’occasione, insomma, non soltanto si affermava, di conseguenza, la proposta di Occhetto ma svaniva la possibilità di ricostruire una adeguata soggettività politica rappresentativa della storia fondamentale per il movimento operaio italiano.
L’occasione di Arco fu, a mio giudizio, l’ultima nella quale si dimostrò concretamente il significato di “radicamento sociale” per una forza politica.
Dunque, al termine dell’intervento di Ingrao l’assemblea di Arco si sciolse per “forza naturale” ed i partecipanti si divisero in innumerevoli capannelli, nel massimo della confusione: ad alcuni fu chiaro che quella scelta, di divisione, avrebbe provocato immediatamente la dispersione delle forze anche a livello di base e di periferie.
Con Arco furono mandati a casa e mai più recuperati centinaia di migliaia di militanti e disperso un patrimonio culturale diffuso accumulato in 40 anni di lotte e di esperienza di pedagogia politica.
Ciò accadde puntualmente: mentre l’assemblea di Arco si scioglieva, ed i 200 dirigenti della sinistra comunista lì presenti abdicavano, idealmente in tutto il Paese partiva la diaspora e l’abbandono.
Una responsabilità storica che mi pare pesi ancora adesso
Ritorno dunque all’analisi del dibattito svoltosi nel seminario: non apparve, nell’occasione, pienamente convincente il richiamo, che pure è stato insistentemente svolto, alla questione dell’identità.
Il problema, infatti, non risultava, allora, proprio in ragione della contingenza temporale in cui era caduta la convocazione dell’assemblea, essere quello della “scissione/non scissione”: quanto, piuttosto, quello della collocazione politica, vera e complessa, dell’identità comunista italiana.
Nella relazione di Magri risultava ben presente il rifiuto, ampiamente e ragionevolmente motivato, di legare indissolubilmente il tema dell’identità comunista italiana, alla crisi verticale dei cosiddetti “socialismi realizzati”.
Le conclusioni che il dibattito aveva tratto, proprio attorno a questo specifico argomento, sono però risultate misurate attorno ad un asse di ragionamento che ha lasciato parecchi punti in sospeso.
E’ mancata infatti, almeno a mio avviso, la capacità di spingere oltre a quella impostazione “togliattiana” del seminario a cui già accennavo, proprio il tema cruciale dell’identità.
Si tratta di un giudizio politico che credo proprio di dover sostenere con convinzione anche a distanza di tanto tempo, senza sollevare alcune ombra polemica ma solo per introdurre alcuni elementi di approfondimento all’interno di un dibattito che risulterà certamente ancora lungo e tormentato.
Motivo meglio il perché di questo giudizio: del ravvisare, cioè, anche all’interno dell’area di quelli che si erano denominati come “ comunisti democratici”, un deficit di motivazione politica nel sostenere la necessità di una presenza, appunto pienamente politica, dell’identità comunista in Italia.
Una necessità di presenza pienamente politica collocata, beninteso, al di fuori da quelle logiche di massimalismo arroccato, che pure sono presenti nel dibattito in corso e sulle quali alcuni puntano in maniera fin troppo disinvoltamente scoperta.
Un deficit di motivazione politica che deriva da una visione distorta del grado di continuità con il togliattismo che si intende, più o meno consapevolmente, mantenere e che si è, appunto, avvertita tangibilmente nel corso del seminario.
Il problema, rappresentato dalla velata riproposizione dell’identità togliattiana a sostegno dell’ipotesi di continuità nella presenza politica dei comunisti italiani andava quindi affrontato, per davvero, attraverso una proposta di rifondazione riguardante, però, non soltanto il complesso dei rapporti interni all’area comunista, o ex-comunista, o post-comunista, ma l’insieme dei rapporti a sinistra consolidatisi nella realtà politica del Paese.
Mi permisi, allora, di riassumere molto brevemente i punti che ritenevo risultare costitutivi di una possibile rifondazione della nostra identità comunista, basandomi su alcuni elementi che ritengo, ancor oggi, irrinunciabili e che rappresentano, almeno a mio modesto giudizio, il punto di saldatura tra la decisiva impostazione gramsciana del ’26 ed i successivi aggiustamenti seguiti alla necessità (politicamente giustificata ampiamente) di seguire, per lungo tempo, le evoluzioni strategiche dell’Internazionale Comunista.
Penso, cioè, al punto vero di saldatura consolidatosi tra Gramsci e Togliatti.
Un punto di saldatura verificatosi a livello altissimo non certo di compromesso, attorno ad un riferimento di tipo universale ed alla prospettiva, concreta, non relegata nel libro dei sogni, di una originale evoluzione del processo rivoluzionario in Occidente.
1. Da quell’intreccio, da quel punto di saldatura, sviluppatosi progressivamente nel corso degli anni che rimangono i più difficili del secolo scorso, ne derivava che Gramsci e Togliatti lavoravano sulla necessità di formare, attraverso un lento e articolato lavoro di lotta sociale e politica, un blocco storico anticapitalistico. Una lezione valida tanto più oggi, alla vigilia dell’apertura di un nuovo ciclo nella storia d’Europa, per l’esistenza di pressanti ragioni di complessificazione del sistema sociale e di radicalizzazione della lotta politica, rispetto alle quali la realizzazione di un “metodo politico dell’alternativa” in luogo di un semplice “schieramento dell’alternativa” rimane il solo sbocco politico in positivo. L’utilizzo della mediazione praticabile da forze politiche profondamente ramificate nel senso comune di massa, smantellando un apparato egemonico costruito dall’avversario per costruirne uno radicalmente alternativo. L’operatività di un partito in grado di agire non come una semplice avanguardia, come come intellettuale collettivo, promotore di una riforma intellettuale e morale.
2. L’esigenza, infine, di fare tutto questo attraverso un non breve processo di lotta, all’interno della società capitalistica, con parole d’ordine intermedie e positive e con una forte attivizzazione e partecipazione di massa.
E’ proprio da questi punti che può, allora, poteva apparire possibile trarre gli elementi maggiormente definitori, di una identità difficilmente alienabile:
a) l’accentuazione dell’idea della rivoluzione come processo sociale, definendo così, immediatamente, un rapporto di profondo intreccio fra ricerca sulle forme della democrazia e la prospettiva del socialismo;
b) l’accentuazione sulla necessità di produrre un concreto processo sociale; sull’elemento cioè della transizione come lunga fase storica che porta in primo piano il tema delle alleanze e del primato del potere politico.
Attorno a questi due punti non si era realizzata, a cavallo dell’avvento del fascismo, una semplice scissione tra socialisti e comunisti: i comunisti italiani rifiutarono, a quel punto ed in una misura assai più rilevante di altri in Occidente, la storia e la tradizione della II internazionale.
Un rifiuto che originava, quindi, da ragioni storiche ben più profonde, di quelle derivanti dalla volontà di applicare integralmente i dettati dell’Internazionale comunista.
Un rifiuto che derivava dall’individuare nell’economicismo piattamente evoluzionista, il limite storico dell’esperienza riformista.
Si trattava, allora, di ritornare alla realtà , dell’individuazione di questo limite per comprendere come risulti, adesso, del tutto essenziale l’autonomia teorico – politica dell’area comunista italiana.
Non hanno saputo far questo, i comunisti italiani, indipendentemente dalla loro contingente collocazione organizzativa proprio nel momento della proposta di scioglimento del Partito.
Era attorno a questi nodi che andava superato Togliatti, senza bruciare alcun vascello, ma anzi valorizzando al massimo il dato di una indispensabile “continuità dinamica”.
Il partito dell’alternativa,che avrebbe dovuto raccogliersi attorno all’identità comunista, doveva dunque essere posto in condizione, proprio sulla base di una seria riaffermazione delle questioni teoriche di fondo, di liquidare ogni limite di strumentalismo e di giacobinismo che rischiavano, invece, di riaffiorare nell’insieme della proposta di nuova formazione politica avanzata dall’allora maggioranza del PCI, in particolare quando si assunsero riferimenti riguardanti l’azionismo o il “socialismo liberale”.
Gli esiti di quelle sciagurate scelte sono oggi sotto gli occhi di tutti.
Per scongiurare davvero il rischio incombente dell’estirparsi, in Italia, delle radici della conflittualità alternativa, si trattava allora di riportare in campo, fuori da qualsiasi auto-limitazione di tipo tattico, almeno due nozioni: quella di “egemonia” e quella di “identità di sistema”, sulla quale andava sviluppata l’articolazione di un rapporto politica e società, in grado di riaggregare la realtà di un nuovo blocco sociale.
Rifondazione Comunista non ha rappresentato nulla di tutto questo assestandosi, dopo un tumultuoso periodo di formazione contrassegnato da crisi legate essenzialmente ai temi dello schieramento politico, con la segreteria Bertinotti si di un intreccio tra accettazione del divismo politico, movimentismo e politicismo filo – governativo in una chiave complessiva di massimalismo d’antan e di scorciatoia nella rappresentanza istituzionale (almeno fino a quando è stato possibile).
Con Arco si era comunque chiusa almeno a mio avviso la storia della sinistra comunista in Italia: sarebbe il caso, adesso, per dare un senso logico a questo itinerario che mi riprometto di percorrere di tentare un bilancio, del tutto approssimativo, degli esiti dello scioglimento del PCI sull’intero sistema politico italiano (ed oltre), tenuto conto che, nel giro di pochissimi anni, fattori interni ed internazionali (trattato di Maastricht, Tangentopoli, caduta del Muro di Berlino, avvio e arretramento della globalizzazione, egemonia neo liberista, apertura di nuovi fronti di guerra, contraddittoria crisi dello Stato – Nazione,) hanno provocato l’avvio di una tumultuosa fase di transizione che, ancora adesso, stiamo vivendo e che per certo non possiamo dare per conclusa.
di Franco Astengo