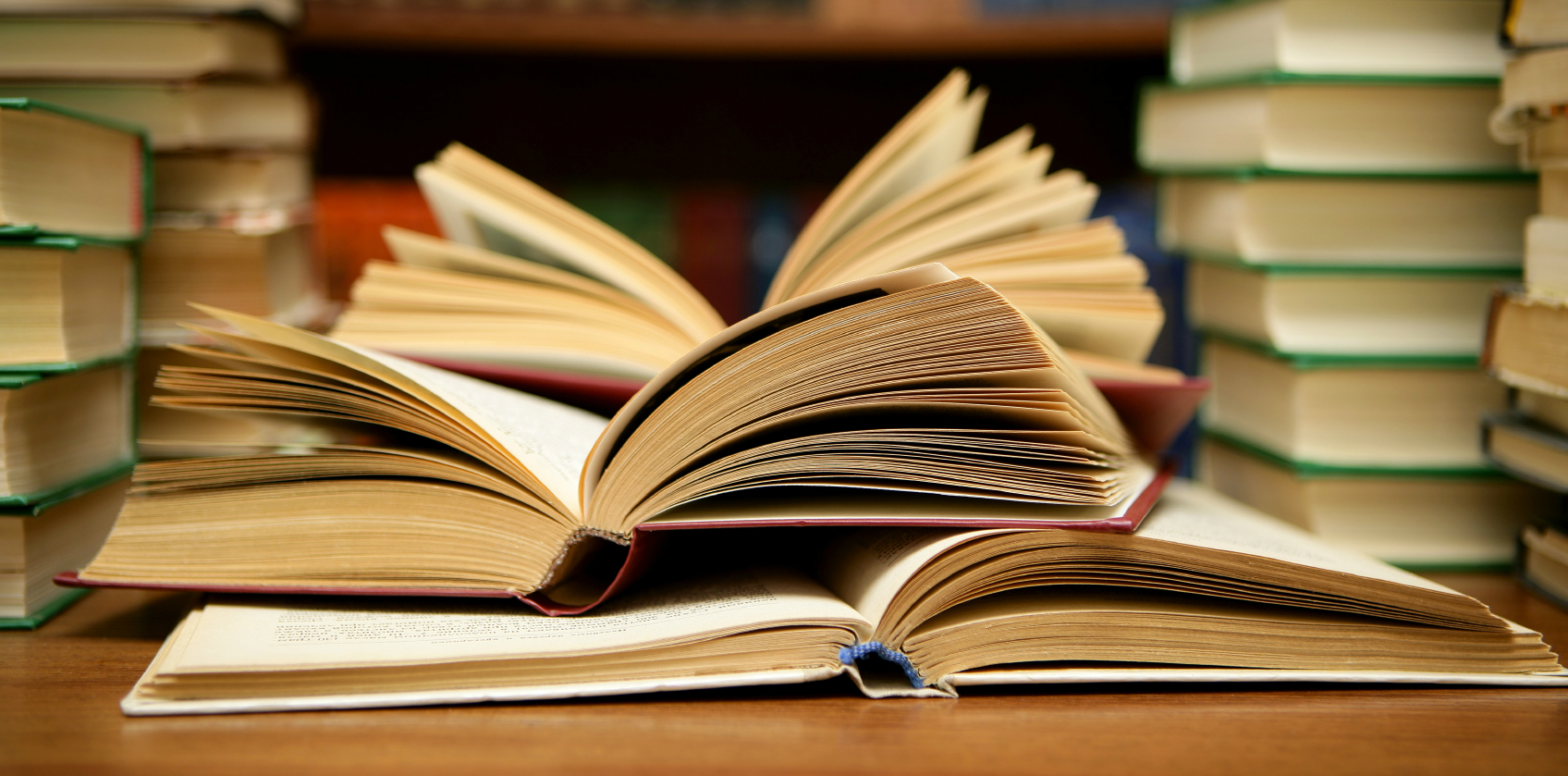di Patrizio Andreoli, Segreteria Nazionale PCI
Se ai tempi del Covid la cultura è dichiarata “superflua”
Il nuovo DPCM emanato dal Governo, ha inibito per trenta giorni lo svolgimento delle attività teatrali, musicali e più in generale dell’intrattenimento e dello spettacolo. Il Presidente del Consiglio Conte rispondendo in queste ore all’appello-denuncia del maestro Riccardo Muti, riconosce che si è trattato di una scelta “oggettivamente grave ma necessaria (…) tesa ad evitare “assembramenti ed ulteriori fonti di contagio”, rispetto ai cui effetti saranno attivati ristori economici a favore dei lavoratori del settore.
Se anche a ciò si corrispondesse in via adeguata ed in tempi rapidi (e vi sarà molto, oltre gli annunci, da vigilare e capire), davvero non saremmo in presenza di nodo alcuno? Già, perché al netto di una valutazione circa il meglio operare o meno nella congiuntura data, la questione che si pone è notevole e non banalizzabile, segnando per molti versi in via non nuova “la specificità” e percezione della cultura quale filo del tessuto profondo da secoli costitutivo parte larga del sentire del Paese, e dunque del rapporto tra cultura e storia nazionale, tra questa e il potere.
Il punto di frattura che storicamente continua a pesare in maniera “originale” segnando tuttora scelte e senso comune, è il persistere pervasivo e persino stupefacente dato il progressivo conformarsi della società in cui
viviamo ai dettami della società globale e di massa, di una resistente visione idealistica o propria di una corrotta lettura romantica della cultura, intesa come universo dell’anima distante e (di-)staccato dalla materialità della vita (e quindi non di questa nutrimento primario necessario) che “non produce pane e non sfama”. Con la cultura non si mangia! Quante volte abbiamo udito e data per confermata tale asserzione (peraltro oggi più di ieri profondamente errata). In un Paese di “santi, di navigatori e di poeti”, la poesia è talora sublime ma i suoi autori muoiono per definizione di stenti, i pittori talora sopravvivono appena meglio, i musicisti – nell’Italia che ha inventato il teatro in musica e vanta il più formidabile patrimonio di tradizione lirica – , sono degli sfaccendati sognatori da ingaggiare all’occasione.
I registi e gli uomini di cinema sono in genere da considerarsi una specie a parte, tra scandali e gossip a cui, per l’appunto, la morale corrente rilascia
una passaporto speciale. Si sa, si tratta di gente inaffidabile e da guardarsi con sospetto; in fondo che cosa si pretende, sono solo attori. Sposare un artista è sposare uno senz’arte e né parte che non saprà garantire un
futuro per sé e per la propria famiglia …e via dicendo, snocciolando un almanacco infinito di luoghi comuni e stereotipi deteriori e pur tuttavia potenti. Insomma d’arte (e di cultura in genere) non si vive, al massimo si
può lecitamente morire a conferma di un’accezione caricaturale che vuole i pittori “maledetti”, i poeti “incompresi”, i musicisti “geniali ma in anticipo sul gusto del proprio tempo”. Da questo punto di vista, lo sguardo del potere non si è allontanato molto, da quello che accoglieva tutto sommato ritenendo le loro irriverenze tollerabili, i vari Rigoletto alla propria corte; o cacciava i saltimbanco allo scoccare della quaresima dalle pubbliche piazze.
La tv e i social, nell’epoca del pensiero unico e dello smarrimento di una coscienza e di uno sguardo critici sul presente, hanno semmai enfatizzato il carattere volgare e plebeo della proposta informativa, d’intrattenimento (che di per sé non è sinonimo di proposta vacua e ininfluente) e culturale.
Tale visione della cultura e della sua percezione da parte del potere, in Italia ha ragioni antiche. Essa è riconducibile alla frattura tra la cultura (un tempo avremmo detto “alta”) fiorita e promossa presso le corti ducali e le signorie quale prologo vitale della nostra identità nazionale ed unitaria di là da venire; e la cultura popolare spesso a quel potere d’istinto resistente, a lungo tramandata oralmente e per via sapienziale (motti, proverbi, modi di dire e di “pensare il mondo”) mobile e per sua natura liquida, fissatasi più lentamente e solo in via parziale in produzione codificata.
Si deve aggiungere come mentre “l’umanesimo” per caratteristiche e profilo propri si proponeva quale leva di una visione universale e per ciò stesso eversiva; i molti “particulare” del potere/dei poteri di guicciardiana memoria che a lungo si continueranno a coltivare e difendere, segnavano una tenace azione di resistenza al processo di unificazione politica e alla costruzione dell’identità italiana. Da qui la doppia lettura da parte del potere circa il ruolo della cultura al bisogno vista per un verso come superflua; per l’altro come potenzialmente pericolosa se non direttamente perniciosa. Un sospetto del potere, tuttora sospeso o in essere. La cultura doveva a suo tempo essere orpello e fonte di godimento, biglietto da visita dello status del ceto gentilizio che “pensava ciò che pensava il Principe” a conferma della sua magnificenza e vocazione al mecenatismo; pur tuttavia senza mai occuparsi di politica, di coscienza e formazione civile, di rivoluzione degli animi.
Quando questo accadrà soprattutto da Machiavelli in poi (anch’esso, non si dimentichi, nei suoi anni uomo di lettere e non solo protagonista della vita pubblica), si darà vita così a qualcosa di inedito nel panorama nazionale, ovvero alla pericolosa nascita, in via distinta, della scienza politica moderna. Né in Spagna, né in Francia, né in Germania (e potremmo aggiungere ancora altri contesti ed esempi di radici culturali) il proprio tessuto e patrimonio culturale sono avvertiti e vissuti in tale modo. Ciò ha molte cause, a partire dalla nostra giovane e fragile unità nazionale (appena 150 anni), dalla realizzazione di un’identità incerta ed ancora in cammino; dal ruolo a lungo subalterno al potere – quando non cortigiano e servile – di parte della nostra intellettualità fatta salva quella più feconda ed avvertita che spesso risultando nel Paese minoranza civile e morale, tra l’età dei lumi ed il novecento ha svolto un ruolo disperato di formidabile semina critica, avviando l’Italia alla modernità.
Ultima per significatività, spessore e dignità culturale, novità nella storia d’Italia, quella figlia dell’antifascismo intesa esattamente nella sua accezione di saldatura tra coscienza critica e coscienza politica, tra indagine intellettuale, produzione culturale a partire dallo sguardo sulla condizione sociale degli uomini.
Ma quella frattura tra potere e cultura resta. Resta il sospetto del potere circa il vero potere, dietro il dileggio, di Rigoletto. Resta il timore del carattere sovversivo della cultura, quella autentica, ovverosia quella che
veicola bellezza rivelandosi universale a tutte le latitudini. Resta la derubricazione della cultura a passatempo dell’anima e non a leva di resistenza dell’anima contro la sua possibile corruzione e i mali del mondo. Un errore grave che segna il provincialismo e lo sguardo corto della nostra classe politica. Non so se davvero l’aver chiuso teatri, cinema e luoghi di spettacolo (che peraltro già agivano nel rispetto di quanto prescritto in
termini di contenimento dell’epidemia) ci salveranno dall’ulteriore diffusione del Covid. In merito ho seri dubbi.
So per certo quanto potrebbero aver indebolito il nostro animo a resistere. Sento personalmente, che quando ci si trova intubati in rianimazione, per continuare a vivere serve aggrapparsi a molte cose lungo labirinti insondabili e per ciascuno unici. Tra questi, credo fermamente vi sia la bellezza di vivere di cui l’arte e la cultura traducono tanta parte. Ecco perché trovo irricevibile l’affermazione di alcuni esponenti del Governo
che nei giorni scorsi hanno definito la cultura superflua. Chi definisce la cultura superflua o è disposto a farlo in nome “dell’imperiosità” del momento, ha già abdicato alla vita disponendosi al proprio annientamento
morale e civile ed è prossimo ad uccidere una parte di sé.
E’ prossimo ad accettare di respirare senza pensare (come se questo fosse possibile senza perire). Ha messo in conto di regredire senza troppo opporvisi. E’ già in cammino – ne sia o meno consapevole – nell’opera di annichilimento del genere umano, o per meglio dire di ciò che più di altro rende il genere umano profondamente unico ed autentico.
Il 9 agosto 1942 nella Leningrado sotto assedio la Grande Orchestra Sinfonica sotto la direzione di Karl Eliasberg (di nazionalità tedesca) eseguì la settima sinfonia di Dmitrij Šostakovič. I tedeschi avevano l’intenzione di occupare la città ed in proposito stavano addirittura preparando gli inviti al banchetto nel ristorante dell’hotel “Astoria”. Il giorno dell’esecuzione tutte le forze dell’artiglieria di Leningrado furono gettate nelle postazioni nemiche. Nonostante le bombe e gli attacchi aerei, nella Filarmonica erano stati accesi tutti i lampadari.
La sinfonia fu trasmessa alla radio, così come dagli altoparlanti della rete urbana. La ascoltarono non solo i residenti, ma anche le truppe tedesche che assediavano Leningrado, le quali credevano che la città fosse ormai praticamente morta. Dopo la guerra, due ex soldati tedeschi, che avevano combattuto nei pressi di Leningrado, rintracciarono Eliasberg e gli confessarono: “Allora, il 9 agosto 1942, ci rendemmo conto che avremmo perso la guerra.” Quelle note, valsero se non più, almeno al pari delle munizioni che servivano a resistere e a continuare a combattere. Mentre si moriva letteralmente di fame nella disumanità più totale della guerra, esse contribuirono concretamente a resistere. Sia chiaro – non scherziamo – non si vive senza pane; e pur tuttavia neanche di solo pane. Si vive tenendo conto, sempre, che gli uomini sono quello che mangiano ed insieme quello in cui credono.
Lasciate che la cultura sia parte delle nostre difese immunitarie più profonde capaci di aiutarci a resistere al Covid ed insieme, di salvarci dalle brutture e dalla barbarie del nostro tempo.